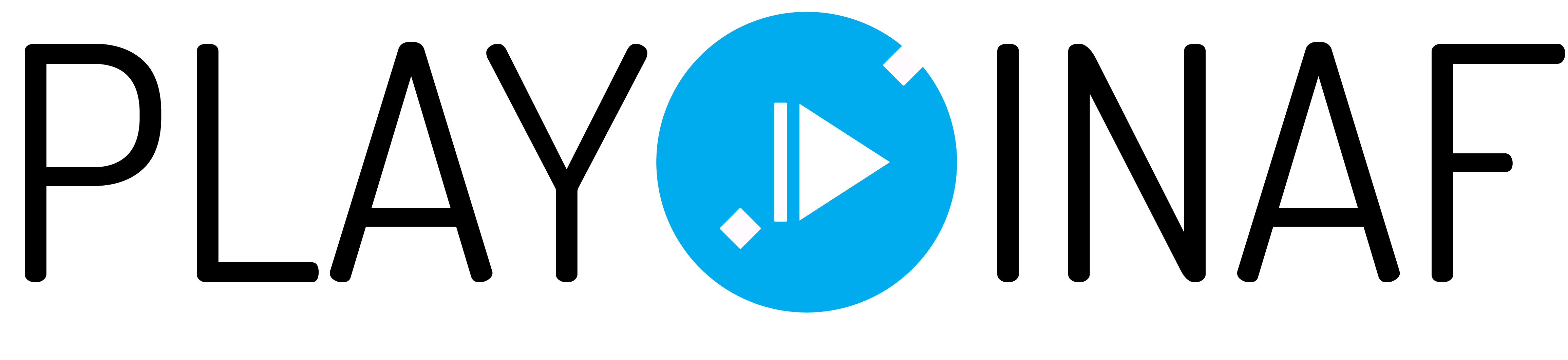Attività didattica progettata da Andrea Farina durante il corso di dottorato “Designing multi-sensory public engagement activities” tenuto all’Università di Padova nel 2025.
Breve descrizione dell’attività
Esistono più di 38.000 asteroidi che si avvicinano molto al nostro pianeta, ma a causa delle loro piccole dimensioni sono invisibili ad occhio nudo e difficili da osservare anche con i grandi telescopi professionali. Solo quando si avvicinano molto alla Terra siamo in grado di osservarli per pochi giorni. In questa esperienza, attraverso l’uso del tatto, dell’olfatto e dell’udito, i bambini avranno l’opportunità di capire come si studiano questi oggetti invisibili al nostro occhio, ma molto vicini a noi.
Materiale necessario per l’attività
Il materiale necessario per l’attività è il seguente (Figura 1):
- 1 kg di pasta da modellare (tipo Das)
- 3 palline di plastica (tipo quelle che si usano per Natale) che si possano aprire a metà
- Sassolini
- 3 scatole di scarpe
- Fogli di carta neri
- Fogli trasparenti
- Materiali per profumi: terra, carbone commestibile e spugnetta di alluminio
- Stelline adesive per decorazioni
- Forbici
- 3 scatolette di carta
- Modellino in plastica di un asteroide (o un oggetto simile che ne simuli la superficie)
- Pallina da Ping Pong
- tempere (grigio chiaro, grigio scuro, nero)

Preparazione dell’attività
La preparazione dell’esperienza si divide in due parti: una prima attività con il radar e una seconda attività tassonomica con i modellini di asteroidi.
Per la prima parte non è necessaria alcuna preparazione specifica; è sufficiente avere con sé il modellino di plastica dell’asteroide (oppure un oggetto simile che ne simuli la superficie) e una pallina da ping pong.
Per la seconda parte, invece, bisogna prendere tre scatole da scarpe e ritagliare, con le forbici, una piccola finestrella sulla parte frontale. Successivamente, occorre fissare con del nastro adesivo un pezzo di foglio trasparente, tagliato in modo da coprire la fessura, come illustrato in Figura 2.

Successivamente, è necessario ricoprire l’intera scatola da scarpe con fogli di carta nera, lasciando scoperta soltanto la parte dove si trova il foglio trasparente. La carta nera rappresenterà il cielo. Infine, si possono applicare degli adesivi a forma di stellina sulla superficie esterna della scatola, per simulare un cielo stellato (Figura 3).

Il passo successivo prevede la creazione di modellini di asteroidi con la pasta modellabile e le palline di natale (Figura 4).

Prendere tre palline di Natale in plastica, di quelle suddivise a metà, e usarle per simulare il peso di tre asteroidi differenti: lasciarne una vuota e riempire le altre due con dei sassolini, in modo da ottenere tre pesi diversi. Successivamente, ricoprire le tre palline con il Das, modellando una forma approssimativamente sferica. Prima che il Das si asciughi, creare dei crateri sulla superficie utilizzando le dita o strumenti casalinghi. Una volta asciutto, dipingere i tre asteroidi con la tempera: usare un grigio chiaro per l’asteroide di tipo S (il più leggero), un nero intenso per quello di tipo C (peso intermedio), e un grigio scuro per quello di tipo X (il più pesante), in modo che risulti una via di mezzo tra gli altri due. Quando i modellini sono pronti (Figura 5), inserirne uno in ciascuna scatola.

Colorare di nero o rivestire coi fogli neri anche le tre scatolette di carta che conterranno gli odori di terra, carbone e alluminio (Figura 6).

Distribuire i materiali all’interno delle tre scatole da scarpe nel seguente modo:
- Scatola di tipo S: inserire l’asteroide più chiaro e leggero, insieme a una scatoletta di carta contenente della terra.
- Scatola di tipo C: inserire l’asteroide più scuro, di peso intermedio, e del carbone nella scatoletta.
- Scatola di tipo X: inserire l’asteroide di colore intermedio, ma più pesante, accompagnato da oggetti metallici.
Infine, praticare dei fori su ciascuna scatola, esattamente in corrispondenza della scatoletta con il materiale odoroso, in modo che i partecipanti possano percepire il profumo (Figura 7).

A questo punto, la preparazione è completata e l’esperienza è pronta per essere svolta.
Nota: nel momento in cui l’attività viene svolta, tutto il materiale deve essere sistemato sul tavolo, con i modellini degli asteroidi e gli odori già inseriti all’interno delle scatole da scarpe corrispondenti in modo che i partecipanti non li possano vedere. È inoltre consigliato inumidire la terra per farne risaltare il profumo.
Descrizione dell’attività
Breve introduzione
L’attività inizia con una breve introduzione sul tema degli asteroidi, raccontando perché sono oggetti importanti e come vengono studiati dagli astronomi. L’obiettivo di questa attività è far conoscere l’esistenza di questi piccoli corpi celesti che passano molto vicino alla Terra e spiegare come vengono studiati dagli astronomi.
Gli “oggetti vicini alla Terra” (NEO, Near-Earth Objects) sono asteroidi e comete la cui orbita li porta a transitare nelle vicinanze dell’orbita terrestre. Provengono prevalentemente dalla Fascia principale degli asteroidi e diventano NEO in seguito a perturbazioni gravitazionali, in particolare dovute a Giove, che modificano gradualmente la loro orbita fino a portarli nelle regioni interne del Sistema Solare.
Verrà inoltre sottolineata l’importanza di tali studi nel contesto della difesa planetaria. La difesa planetaria si occupa di identificare, monitorare e caratterizzare oggetti potenzialmente pericolosi che potrebbero collidere con la Terra. La difesa planetaria è coordinata da enti come la NASA e l’ESA, attraverso un insieme di attività scientifiche e operative finalizzate a proteggere il pianeta dal rischio di impatti con asteroidi e comete. Questi studi permettono di valutare il rischio e, se necessario, di progettare strategie per deviare o mitigare l’impatto di un oggetto in rotta di collisione con la Terra.
Sebbene questi oggetti possano sembrare simili, in realtà ciascuno è unico: differiscono per composizione chimica, dimensioni, porosità e proprietà fisiche. L’attività mira a offrire un’esperienza sensoriale che permetta ai partecipanti di comprendere la varietà degli asteroidi e i metodi utilizzati per studiarli.
Attraverso l’olfatto sarà possibile percepire le differenze di composizione, con il tatto si potrà notare come il peso cambi anche a parità di dimensioni, mentre l’udito consentirà di riconoscere il suono prodotto da un asteroide simulato con la tecnica del radar. Questa esperienza stimola la curiosità e permette di esplorare aspetti poco noti ma fondamentali dei corpi che orbitano vicino alla Terra.
Prima parte
Nella prima parte dell’esperienza, si fa rimbalzare una pallina da ping pong prima sul tavolo e poi sul modellino dell’asteroide in plastica (o un oggetto simile). I bambini devono chiudere gli occhi per ascoltare come cambia il suono a seconda della superficie colpita. Questa semplice dimostrazione serve a spiegare la tecnica del radar utilizzata per studiare la forma degli asteroidi.
Seconda parte
Successivamente, i partecipanti saranno coinvolti in modo interattivo con le tre scatole, ognuna contenente un “asteroide” con caratteristiche diverse. In questa fase, i partecipanti esploreranno gli asteroidi utilizzando il tatto e l’olfatto, scoprendone le differenze in termini di composizione e peso. All’inizio dell’attività, si invita il gruppo a guardare attraverso il foglio trasparente presente sulla scatola: i partecipanti noteranno che all’interno non si vede nulla, a simboleggiare il fatto che gli asteroidi, nella realtà, non sono visibili a occhio nudo.
Successivamente, toccando le scatole, i partecipanti percepiranno che esse hanno pesi differenti. Infine, annusandole, si accorgeranno che ciascuna emana un odore diverso, a rappresentare tre composizioni chimiche distinte.
Gli asteroidi, infatti, vengono classificati in base al tipo di materiale di cui sono composti:
- Gli asteroidi di tipo S (silicatici) sono ricchi di silicati e metalli come nichel e ferro, e tendono ad avere superfici più riflettenti.
- Gli asteroidi di tipo C (carboniosi) sono composti principalmente da materiali ricchi di carbonio e sostanze volatili, sono molto scuri e considerati tra i più primitivi del sistema solare.
- Gli asteroidi di tipo X (metallici), invece, hanno composizioni più eterogenee, spesso contenenti metalli in percentuali variabili, e rappresentano una categoria intermedia, con proprietà sia metalliche sia silicatiche.
Una volta aperta la scatola, i partecipanti noteranno che i tre asteroidi hanno colori diversi, dovuti alla loro differente composizione chimica. Prendendoli in mano, si accorgeranno che hanno anche pesi differenti.
Attraverso il tatto, percepiranno non solo la differenza di peso, ma anche la superficie irregolare dei modellini, che simula la struttura reale di un asteroide.
Conclusione
Alla fine dell’attività, i bambini saranno invitati a condividere le loro osservazioni e a trarre delle conclusioni. L’esperienza si concluderà con alcune domande guidate e una breve spiegazione sul perché questi oggetti possano rappresentare un pericolo, e per questo motivo esistono programmi di monitoraggio e missioni spaziali dedicate.
Domande possibili:
1) Cosa ti ha sorpreso di più sugli asteroidi?
2) Cosa potrebbe succedere se un asteroide molto grande colpisse la Terra? Secondo te, ci sono stati degli impatti di asteroidi in passato?
3) Perché è utile sapere dove si trova un asteroide e di cosa è composto?
4) Secondo te, tutti gli asteroidi sono pericolosi?
5) Cosa possiamo fare per proteggerci da un asteroide che si avvicina troppo?
6) Cosa succederebbe se un grande asteroide colpisse il mare invece della terraferma?
7) Come proteggeresti la Terra se arrivasse un asteroide?
8) Se tu fossi uno scienziato, quale tipo di asteroide vorresti studiare e perché?
9) Come pensi che gli asteroidi abbiano aiutato la Terra a diventare com’è oggi?
Approfittare di queste domande per ricordare che gli asteroidi hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia della Terra, portando acqua e materiali organici che potrebbero aver contribuito all’origine della vita.
Descrizione del processo fisico
Gli asteroidi vengono classificati in base alla composizione chimica e mineralogica del loro materiale superficiale: quando il Sole illumina gli asteroidi, questi assorbono e riflettono la luce, e il modo in cui lo fanno dipende dalla loro composizione. Attraverso l’uso di telescopi sulla Terra, possiamo studiare la luce riflessa dagli asteroidi utilizzando una tecnica chiamata spettroscopia.
La spettroscopia è una tecnica che consente di analizzare la luce proveniente da un oggetto celeste separandola nelle sue componenti spettrali (cioè nelle diverse lunghezze d’onda che la compongono) facendo uso di uno strumento chiamato spettrografo. Ogni materiale ha una firma spettrale unica, che corrisponde alla luce che assorbe o riflette a specifiche lunghezze d’onda.
Quando la luce raggiunge il telescopio, essa viene prima raccolta e poi indirizzata verso lo spettrografo, che utilizza un elemento dispersore (come un prisma o un reticolo di diffrazione) per separare la luce nelle diverse lunghezze d’onda. Successivamente, la luce separata viene registrata da un sensore (come un CCD): in questo modo si ottiene uno spettro dettagliato della luce riflessa dagli asteroidi, ossia una rappresentazione delle intensità della luce a diverse lunghezze d’onda. Una volta ottenuti gli spettri, gli astronomi ne analizzano le caratteristiche (come la presenza di righe di assorbimento e la pendenza dello spettro) e ricavano una serie di informazioni sull’asteroide in esame tra cui la composizione chimica, visto che ogni elemento chimico o minerale ha una sua “impronta” spettrale unica.
La tassonomia degli asteroidi è un sistema di classificazione che raggruppa questi corpi celesti in diverse categorie in base alla loro composizione chimica e alle caratteristiche spettrali. Una delle prime tassonomie fu quella proposta da Tholen, che si basava su misurazioni spettrofotometriche nelle lunghezze d’onda visibili e sull’analisi dell’albedo. L’albedo è una misura di quanto la superficie di un oggetto riflette la luce solare: un valore alto indica una superficie riflettente, mentre un valore basso indica una superficie più scura. Successivamente, le due tassonomie proposte da Bus e Binzel e da Bus e DeMeo hanno ampliato il sistema introducendo l’analisi degli spettri nell’ottico (per Bus & Binzel) e nel vicino infrarosso (per Bus & DeMeo). Quest’ultimo approccio ha migliorato significativamente la classificazione, poichè l’infrarosso consente di rilevare caratteristiche chimiche e mineralogiche che non sono visibili nell’ottico.
La classificazione tassonomica oggi adottata raggruppa gli asteroidi in tre grandi famiglie (S-type, C-type, X-type) che sono poi ulteriormente suddivise per un totale di ben 24 classi.
- Tipo S: gli asteroidi di tipo S sono rocciosi e molto comuni nella parte più interna della Fascia principale degli asteroidi (compresa tra Marte e Giove). Questi asteroidi hanno spettri con una forte componente rossa e presentano caratteristiche tipiche, come bande di assorbimento a 1 e 2 micrometri, che sono dovute principalmente alla presenza di olivina e pirosseni. Questi minerali contengono ferro e magnesio e sono comuni nelle rocce vulcaniche.
- Tipo C: gli asteroidi di tipo C sono carbonacei e sono comuni nella parte più esterna della Fascia principale. I loro spettri sono generalmente piatti e poco distintivi. L’assorbimento nella banda ultravioletto (UV) è un’indicazione della presenza di silicati idrati, che suggerisce una maggiore quantità di acqua legata chimicamente nei loro minerali. Gli asteroidi di tipo C sono tra i più primitivi e possono contenere i materiali di base che hanno contribuito alla formazione del Sistema Solare.
- Tipo X: gli asteroidi di tipo X sono caratterizzati da composizioni metalliche e rocciose, spesso basate su ferro-nichel. I loro spettri sono generalmente piatti e privi di caratteristiche distintive, il che suggerisce una composizione omogenea, spesso ricca di metalli. Questi asteroidi potrebbero essere frammenti di corpi celesti più grandi che hanno subito processi di differenziazione interna, separando il metallo dal materiale silicato.
Il radar è una tecnica che sfrutta le onde elettromagnetiche per rilevare oggetti e studiarne alcune caratteristiche come la forma o la velocità cui si stanno muovendo. Il principio di funzionamento del radar si basa sull’emissione di impulsi di onde radio, che viaggiano attraverso lo spazio e si riflettono sugli oggetti in grado di interagire con queste onde, come gli asteroidi. Questi impulsi radar, dopo aver colpito l’asteroide, ritornano verso la Terra, dove vengono rilevati da un ricevitore. L’analisi del tempo che impiegano per tornare e dell’intensità del segnale riflesso permette di calcolare la distanza e, indirettamente, altre proprietà fisiche dell’oggetto. Le onde radar che colpiscono un asteroide riflettono in modo diverso a seconda della superficie e della geometria dell’oggetto. Se l’asteroide ha una superficie irregolare, le onde radar verranno riflesse in maniera dispersa, mentre se la superficie è liscia, il segnale sarà più uniforme. Inoltre, studiando il ritorno del segnale in diverse angolazioni, è possibile ricostruire la forma tridimensionale dell’asteroide. Questo metodo, noto come radar imaging, consente di ottenere mappe della superficie e delle dimensioni precise degli asteroidi, anche se questi sono troppo lontani o troppo piccoli per essere osservati direttamente con altri metodi ottici. Il radar è quindi uno strumento che permette di ottenere dettagli sulla morfologia e le caratteristiche superficiali degli asteroidi, come la presenza di crateri o la forma complessa di oggetti rotanti.