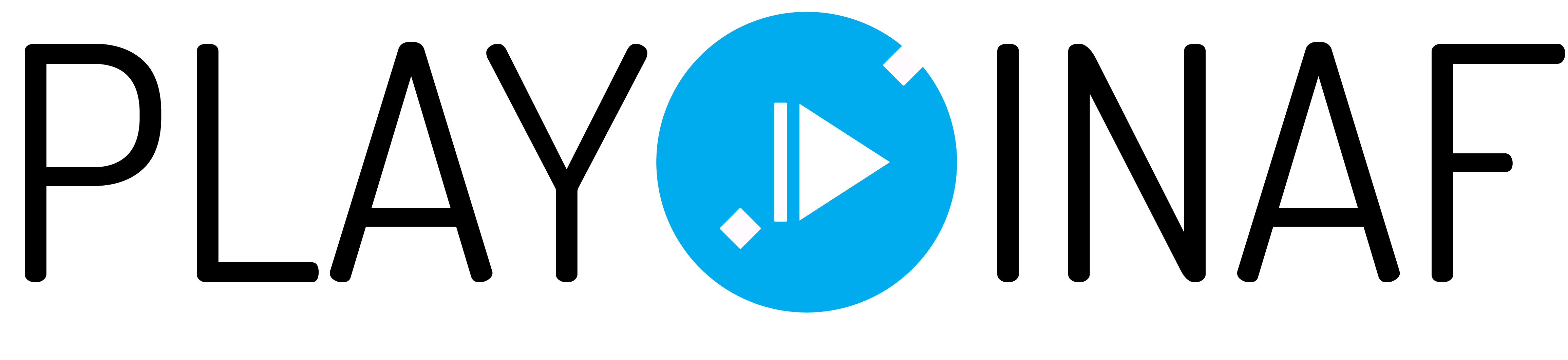Attività didattica progettata da Irene Salmaso e Erika Korb durante il corso di dottorato “Designing multi-sensory public engagement activities” tenuto all’Università di Padova nel 2025.
Breve descrizione dell’attività
Il laboratorio ha lo scopo di sensibilizzare su cause ed effetti della progressiva scomparsa del buio dai nostri cieli. I partecipanti scopriranno che l’aumento delle luci artificiali produce effetti negativi per l’astronomia e per gli ecosistemi. L’attività comincerà con un viaggio dal centro cittadino fino al deserto di Atacama, in cui i partecipanti potranno vedere e toccare con mano come cambia il numero di stelle che è possibile distinguere in cieli diversamente inquinati. In seguito, i partecipanti sperimenteranno in prima persona la difficoltà degli astronomi di estrarre poche informazioni utili in un mare di rumore. Proveranno a usare le informazioni raccolte per imparare qualcosa sul buio e tenteranno di orientarsi come un animale notturno. Infine, si discuterà delle cause dell’inquinamento luminoso e dei comportamenti che si possono adottare per ridurlo.
Materiale necessario
Il materiale necessario per svolgere l’attività è il seguente (Figura 1):
- Cartoncino neri
- Carta da forno
- Graffette o colla
- Perline e colla oppure glitter
- (opzionale) foto stampata della via lattea e di un elemento architettonico cittadino riconoscibile, ad esempio una torre, per aiutare l’immersione
- Matite bianche e gialle oppure tempere e pennelli
- Gomma, temperino e forbici
- Benda o mascherina da notte
- 3 fatti sul buio, scelti da una lista in base all’età del pubblico (vedi appendice)

Preparazione dell’attività
Prima dell’inizio dell’attività, è necessario preparare il supporto cartaceo che servirà per simulare l’effetto dell’inquinamento luminoso su un cielo stellato.
Per creare la volta celeste ci sono due possibilità:
- stampare una foto della Via Lattea e incollarla ad un cartoncino;
- disegnare la Via Lattea su un cartoncino nero con tempere e matite colorate.
In entrambi i casi, è consigliato aggiungere glitter e perline o stickers al disegno, in particolar modo sul tracciato della Via Lattea, così da renderlo più evidente e facile da riconoscere anche con il tatto. Ora basterà graffettare o incollare qualche foglio di carta da forno su uno dei due lati corti del cartoncino per ottenere diverse gradazioni di cielo inquinato.
Anche qui ci sono due possibilità (Figura 2):
- ritagliare tutti i fogli di carta forno della stessa dimensione del cartoncino, e sovrapporli;
- ritagliare ogni strato leggermente più corto dell’altro.

Per rendere più realistico lo scenario, si consiglia di aggiungere vicino al bordo di ogni strato di carta forno un elemento architettonico cittadino (ad esempio la torre di Figura 3), avendo cura di scurirlo man mano che ci si sposta verso zone più buie (cioè meno inquinate dal punto di vista luminoso).

Descrizione dell’attività
L’attività si svolge in cinque macro-fasi. Nelle prime tre, i partecipanti sperimenteranno:
- un viaggio (simulato) dai cieli inquinati della città a quelli bui del deserto
- la difficile ricerca di un’informazione nascosta in un ambiente inquinato
- il disorientamento degli animali notturni, in una versione alternativa di mosca cieca
Al termine, seguirà una discussione per riflettere sulle azioni che possiamo fare per ridurre l’inquinamento luminoso. Infine, i più piccoli potranno liberare la loro creatività e disegnare su un cartoncino nero un cielo stellato da portarsi a casa, con la possibilità di aggiungerci uno strato di carta da forno per ricordarsi gli effetti dell’inquinamento luminoso.
Fase 1: In viaggio verso il buio
L’attività inizia domandando ai partecipanti che cosa viene loro in mente quando sentono la parola “buio”. Questa parola dà loro sensazioni positive o negative? Hanno paura del buio o ne hanno avuta quando erano piccoli?
Poi, gli si chiede se hanno mai sentito parlare di inquinamento luminoso. Si chiede loro di provare a descriverne gli effetti e ipotizzare se sia un fenomeno che si verifica ovunque o solo in certi luoghi. Si testano le loro teorie, seguendo il metodo scientifico. Siccome è giorno, non si possono fare osservazioni dirette ma bisogna simulare un cielo notturno. Perciò, si utilizzerà il supporto cartaceo creato in precedenza e si narrerà la storia di un viaggio. L’avventura inizierà una notte nel centro cittadino e il supporto presenterà tutti gli strati di carta da forno, impedendo di scorgere il cielo sottostante. Si chiede ai partecipanti di dire quante stelle vedono o sentono (toccando il supporto); è verosimile che non vedano né sentano alcunché proprio a causa delle luci della città (rappresentate dai diversi fogli di carta forno sovrapposti). Sfogliando la prima pagina, il viaggio si sposta dalla città a un piccolo bordo. Far notare come cambia l’elemento identificativo scelto presente nell’angolo in basso di ogni foglio. Si chiede nuovamente ai partecipanti se ora vedono o sentono delle stelle. Qui ne dovrebbero vedere/sentire qualcuna in più. In seguito, si rimuove un altro strato di carta da forno e ci si sposta in aperta campagna, dove ci sono solo alcune case sparse e poche strade e si ripete. Al foglio successivo ci si sposta in una zona remota, come un bosco in alta montagna, dove le luci sono lontane e confinate al fondo valle. Infine, sollevando l’ultimo strato si vede il cielo da un luogo come il deserto di Atacama, dove ci sono i più grandi telescopi del mondo.
Fase 2: Cosa significa inquinamento?
Abbiamo quindi capito che l’inquinamento luminoso ci impedisce di vedere le stelle, eccezion fatta per quelle più brillanti. Questo è un problema non solo perché parte di questo patrimonio naturalistico non ci è accessibile ma aggiunge delle difficoltà anche al lavoro degli astronomi, che dalle stelle ricavano molte informazioni.
In questa fase vanno selezionati tre “fatti sul buio” dalla lista in appendice, uno dei quali deve essere obbligatoriamente il “fatto necessario”.
- Si scelgono due volontari dal pubblico, un lettore e un ricevente, e li si posiziona a qualche metro di distanza. Il lettore dovrà leggere il fatto che gli viene consegnato (oppure lo si può far pescare) e il ricevitore dovrà ripetere quanto sentirà con parole sue. Al primo giro si chiede agli altri partecipanti di osservare in completo silenzio. In questo modo, l’informazione verrà trasmessa completamente.
- Al secondo giro (è possibile cambiare lettore e ricevente dopo ogni turno per far provare un po’ tutti), si chiede al resto dei partecipanti di bisbigliare/parlare tra di loro con tono di voce normale (a seconda se si svolge l’attività al chiuso o all’aperto). A questo stadio, l’informazione dovrebbe passare ma in forma non completa oppure con grande sforzo da parte del ricevente, che deve concentrarsi molto per distinguere le parole del lettore.
- Al terzo giro, si dà al lettore il “fatto necessario” e si chiede ai partecipanti di gridare e battere le mani. Il ricevente non capirà nulla. Alla fine, uno dei facilitatori del laboratorio leggerà a tutti il messaggio.
Alcune considerazioni che si possono fare a questo punto o quando si verificano: il fatto che il lettore legga con un tono di voce particolarmente alto o basso può facilitare o rendere ulteriormente difficile il compito del ricevente. Questo è simile a quanto accade in astronomia quando si ha una stella più o meno brillante e dunque più o meno difficile da identificare e osservare. Inoltre, se il ricevente si sforza maggiormente per capire il messaggio (per esempio, sporgendosi con l’orecchio verso il lettore), può carpire più informazioni anche in un ambiente mediamente rumoroso, proprio come uno strumento più potente o un telescopio più grande permettono di raccogliere più luce anche da stelle deboli. In generale, comunque, capiamo che quando c’è più rumore, ovvero più inquinamento luminoso, è molto più difficile ricevere informazioni dalle stelle.
Fase 3: Come orientarsi al buio
L’ultimo fatto che abbiamo letto ci ha detto che molti animali si orientano al buio grazie alla luna e alle stelle, ma spesso possono essere sviati dalle luci delle città.
- In questa fase, che si svolge su più turni come la precedente, un partecipante impersonerà la luna e un altro una falena che cerca di orientarsi. Nuovamente, i volontari vengono posti a qualche metro di distanza e la falena viene bendata e fatta girare delicatamente su se stessa in modo da farle perdere l’orientamento. La luna deve guidare la falena a sé dando comandi semplici come “gira a sinistra”, “vai avanti”, eccetera. Al primo stadio tutti gli altri partecipanti stanno in silenzio e si tengono distanti, quindi la falena raggiunge facilmente la luna.
- Al secondo stadio, si aggiungono uno/due ulteriori volontari che avranno il ruolo di lampioni (e i ruoli di luna e falena possono essere scambiati se ci sono molti partecipanti) che si distribuiranno tra la luna e la falena e dovranno cercare di attirare la falena a sé usando le stesse indicazioni della luna. A questo stadio, la falena dovrebbe riuscire comunque a trovare la luna, soprattutto se si tratta di una persona che conosce o se i volontari hanno voci molto diverse, ma farà comunque più fatica che allo stadio precedente.
- Infine, tutti i presenti si uniscono e diventano lampioni, cercando ognuno di sviare la falena. A seconda del numero di partecipanti, questo stadio può essere molto difficile e quasi sicuramente la falena finirà contro un lampione.
Possiamo ora fare qualche domanda al pubblico per stimolare la riflessione. In particolare, a chi ha fatto la falena possiamo chiedere: “Vi è piaciuto sentirvi disorientati?”, “Che emozioni avete provato mentre cercavate la luna?”, eccetera.
Con questa ultima attività abbiamo capito che l’inquinamento luminoso è nocivo anche per l’ambiente, dunque cosa possiamo fare per ridurlo?
Fase 4: Cosa possiamo fare per diminuire l’inquinamento luminoso?
Porre questa domanda ai partecipanti e ascoltare le loro risposte. Per ogni suggerimento, anche se ritenuto poco valido, rispondere sempre in maniera positiva (“idea interessante” e simili) per incoraggiare il dialogo. Nel caso, proporre un’alternativa simile ma più attuabile. Per esempio, un suggerimento potrebbe essere “Non usiamo più l’elettricità”, che può essere corretto dicendo “Bell’idea, però così noi non potremmo vedere più niente e rischieremmo di farci male muovendoci la notte. Potremmo però pensare di chiudere le imposte o abbassare le tapparelle quando fa buio, in modo che la luce che viene dalle nostre finestre non sia visibile dall’esterno”.
Altre buone prassi possono essere:
- spegnere le luci quando non si è in una stanza;
- installare sensori di movimento per le luci da esterno, in modo che si accendano solo al passaggio di una persona;
- preferire lampadine con lunghezza d’onda fissa, così che non diano fastidio nelle altre bande;
- progettare lampade e lampioni stradali schermati che indirizzino la luce solo verso il basso, come mostrato in Figura 4 (qui si può far notare la forma dei lampioni nell’ambiente che ci circonda; se sono tondi significa che emettono luce in tutte le direzioni, andando a inquinare il cielo notturno).
In caso le buone pratiche non vengano fornite spontaneamente dal pubblico, i facilitatori possono proporle loro stessi.

Fase 5: Costruiamo il cielo buio
Per chi vuole, il laboratorio può concludersi con un’attività manuale in cui i partecipanti costruiscono un modello del cielo con vari strati di inquinamento luminoso da portare a casa, simile a quello mostrato all’inizio.
Su un cartoncino nero, i partecipanti possono dipingere o disegnare le stelle, attaccare adesivi e così via, creando la loro versione del cielo stellato. Poi, ritagliando tre strisce di carta da forno riprodurranno l’effetto dell’inquinamento luminoso. Portando il cartoncino a casa, i partecipanti potranno ricordarsi di quest’esperienza e spiegare il problema dell’inquinamento luminoso alle loro famiglie.
Descrizione del processo fisico
Quando pensiamo all’inquinamento, ci vengono subito in mente lo smog, i rifiuti plastici o l’acqua contaminata. Ma esiste una forma di inquinamento più silenziosa e spesso sottovalutata: l’inquinamento luminoso. Si tratta dell’eccessiva o errata diffusione della luce artificiale durante le ore notturne, un fenomeno in costante aumento con l’espansione delle città e delle attività umane.
L’illuminazione pubblica è necessaria per motivi di sicurezza e funzionalità, ma se non è progettata in modo corretto, può avere conseguenze significative su vari aspetti della nostra vita e dell’ambiente. L’inquinamento luminoso è un problema scientifico, ecologico e sanitario.
L’ambito che viene maggiormente toccato dall’inquinamento luminoso è l’astronomia. La luce artificiale che si disperde verso l’alto viene diffusa dalle particelle presenti nell’atmosfera, creando una sorta di alone chiaro che copre le stelle più deboli. Questo fenomeno prende il nome di skyglow. Per esempio, in una grande città si possono vedere a occhio nudo soltanto alcune decine di stelle, mentre in un luogo buio, lontano da fonti luminose, ne sarebbero visibili migliaia. Questo rende molto più difficile non solo l’osservazione amatoriale, ma anche la ricerca scientifica: i telescopi devono essere collocati in zone isolate, a grande distanza dalle aree urbane, come sulla cima di una montagna o nel deserto.
Inoltre, l’inquinamento luminoso può avere effetti negativi anche sulla salute umana. Infatti, il nostro organismo è regolato da un orologio biologico chiamato ritmo circadiano, che segue l’alternanza naturale di luce e buio nelle 24 ore. Durante la notte, in condizioni di oscurità, il cervello produce un ormone chiamato melatonina, fondamentale per il sonno e per vari altri processi biologici. L’esposizione alla luce artificiale durante le ore notturne (per esempio esempio a causa di luci che entrano dalle finestre o schermi accesi) può inibire la produzione di melatonina, causando disturbi del sonno, affaticamento cronico e, in alcuni casi, contribuendo all’insorgere di problemi più seri, come depressione o alterazioni metaboliche. Alcuni studi, ancora oggetto di approfondimento, suggeriscono anche possibili legami con patologie cardiovascolari e tumorali, sebbene queste ipotesi debbano essere valutate con cautela.
Infine, l’inquinamento luminoso ha grande influenza sull’ecosistema. Come gli esseri umani, anche gli animali sono fortemente influenzati dal ciclo giorno-notte. L’inquinamento luminoso può alterare profondamente i comportamenti naturali di molte specie. Gli uccelli migratori, ad esempio, si orientano grazie alle stelle: le luci delle città possono disorientarli, portandoli fuori rotta o causando collisioni contro edifici illuminati. Le tartarughe marine neonate, poi, si dirigono istintivamente verso la luce naturale del mare riflessa all’orizzonte. Ma le luci artificiali delle località turistiche costiere possono confonderle, facendole andare nella direzione sbagliata e compromettendo la loro sopravvivenza. Anche molti insetti notturni, come le falene, vengono attratti in massa dalle luci artificiali, dove spesso muoiono bruciati. Questo ha un impatto a catena su interi ecosistemi, poiché questi insetti sono fondamentali per l’impollinazione e per l’alimentazione di altri animali.
Fortunatamente, l’inquinamento luminoso può essere reversibile, perché è possibile intervenire per ridurlo o eliminarlo. Le soluzioni alla portata di tutti possono essere:
- usare lampade schermate, che dirigono la luce solo verso il basso, evitando la dispersione verso il cielo (soprattutto nei lampioni stradali);
- evitare luci troppo intense o bluastre, preferendo luci calde (come quelle gialle o ambra), meno dannose per l’ambiente e per la salute;
- spegnere le luci quando non servono, ad esempio di notte, nelle vetrine o negli uffici;
- installare sensori di movimento per evitare sprechi energetici;
- promuovere normative locali per una pianificazione dell’illuminazione pubblica più sostenibile.
Anche la sensibilizzazione culturale ha un ruolo importante: capire che la notte buia non è pericolosa, ma è parte dell’equilibrio naturale, è il primo passo per proteggere il cielo stellato.
Appendice: fatti sul buio
Fatto necessario
Alcune specie di tartarughe, uccelli e insetti usano la luce della luna e delle stelle per orientarsi. Questi animali non riescono a distinguere la luce naturale della luna o delle stelle dalla luce artificiale che illumina edifici e strade di notte. Quindi, molti animali sono confusi dalla presenza di luci artificiali e sono spesso attirati verso le città, dove è meno probabile che sopravvivano.
Fatti facoltativi, sceglierne due in base al pubblico
- Il buio si verifica quando non c’è luce. Durante la notte, il Sole illumina l’altra parte della Terra, lasciando il nostro cielo scuro. Tuttavia, il buio totale non esiste quasi mai: anche nelle notti più scure, c’è sempre un po’ di luce proveniente dalle stelle, dalla Luna o persino dalle città vicine. Il vero buio assoluto si può trovare solo in caverne profonde o in stanze speciali chiamate “camere anecoiche”, che assorbono tutta la luce.
- Alcuni animali brillano nel buio. Esistono creature, come le lucciole e alcuni pesci delle profondità marine, che emettono luce nel buio grazie a un fenomeno chiamato bioluminescenza. Questa luce li aiuta a comunicare, attirare prede o difendersi dai predatori.
- Il nostro corpo produce una sostanza chiamata melatonina che ci aiuta a dormire. Questa sostanza viene prodotta soprattutto al buio, quindi dormire in una stanza buia può favorire un sonno più riposante. L’inquinamento luminoso può disturbare il ritmo circadiano umano, influenzando negativamente il ciclo sonno-veglia. Questo squilibrio è stato associato a un aumento del rischio di depressione e altri disturbi dell’umore.
- Molti bambini hanno paura del buio perché non possono vedere cosa li circonda. Tuttavia, è importante sapere che il buio di per sé non è pericoloso. Con il tempo, molti bambini superano questa paura. La paura del buio (nictofobia) è comune nei bambini perché l’oscurità impedisce di vedere i pericoli. Si pensa che questa paura sia un’eredità dei nostri antenati, che dovevano stare attenti ai predatori di notte.
- Oltre l’80% della popolazione mondiale vive sotto cieli notturni inquinati dalla luce artificiale. In Europa e negli Stati Uniti, questa percentuale sale al 99%. Di conseguenza, il 60% degli europei e l’80% degli abitanti del Nord America non riescono più a vedere la Via Lattea.
- L’Italia è il Paese del G20 con la maggiore percentuale di territorio inquinato dalla luce artificiale. Circa il 41% del territorio italiano ha livelli di inquinamento luminoso tali da impedire la visione del cielo stellato durante la notte. Regioni come Lombardia, Campania e Lazio sono particolarmente colpite, con circa tre quarti della popolazione che ha perso la possibilità di osservare la Via Lattea.
- In Italia, si stima che ogni anno vengano sprecati circa 1 miliardo di euro per l’illuminazione pubblica inefficiente. Questo spreco non solo ha implicazioni economiche, ma contribuisce anche all’aumento dell’inquinamento luminoso.
- L’universo è perlopiù buio. Sebbene esistano miliardi di stelle e galassie luminose, la maggior parte dell’universo è costituita da spazio vuoto e oscuro. La “materia oscura” e l’ “energia oscura” rappresentano circa il 95% dell’universo, ma non possiamo vederle direttamente.
- Quando entri in un ambiente buio, all’inizio vedi poco o nulla. Ma dopo circa 20-30 minuti, le tue pupille si dilatano e i bastoncelli nella retina diventano più sensibili, permettendoti di vedere meglio. Si dice che i pirati portassero una benda su un occhio per mantenere una pupilla sempre abituata all’oscurità, in modo da poter vedere meglio sottocoperta, dove era molto più buio.
- Nelle regioni vicine ai poli, come in alcune parti dell’Alaska, della Norvegia o dell’Antartide, il Sole può rimanere sotto l’orizzonte per settimane o addirittura mesi durante l’inverno. Questo fenomeno si chiama “notte polare”.
- Gatti, gufi, lupi e altri animali notturni hanno occhi speciali che catturano più luce rispetto agli esseri umani. Molti hanno anche uno strato riflettente che li aiuta a vedere al buio e fa brillare i loro occhi di notte. Alcuni pesci delle profondità marine, come il pesce abissale o il pesce vipera, vivono in zone oceaniche dove la luce del Sole non arriva mai. Molti di loro hanno occhi enormi o producono la propria luce grazie alla bioluminescenza.